
L’accordo c’è ma cosa cambia? Si è conclusa a Parigi la 21ma conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
14dicembre 2015 di Max Strata
 Ha riunito tecnici e politici di tutto il mondo per trovare un accordo che sia in grado di contenere il surriscaldamento del pianeta entro i due gradi centigradi a fine secolo rispetto alla temperatura media del periodo in cui è iniziata la rivoluzione industriale.
Ha riunito tecnici e politici di tutto il mondo per trovare un accordo che sia in grado di contenere il surriscaldamento del pianeta entro i due gradi centigradi a fine secolo rispetto alla temperatura media del periodo in cui è iniziata la rivoluzione industriale.
L’accordo, tra un generale entusiasmo, è dunque arrivato e immediatamente è stato salutato dai media come una pagina storica per l’umanità. Non c’è dubbio che dopo gli insuccessi delle trattative che avevano segnato un percorso durato oltre venti anni, siamo apparentemente di fronte a qualcosa di nuovo e di auspicabile, se non altro per il fatto che la diplomazia ha battuto un colpo e si è fatta sentire. A guardar bene però, il risultato è tutto qui, poiché di vincolante non c’è niente (e non potrebbe esserci stato) e i singoli Paesi, da quelli più ricchi, a quelli “emergenti”, ai più poveri, continueranno a muoversi ciascuno per conto proprio, autocertificando, gli interventi finalizzati a diminuire le emissioni climalteranti.
 Sulla revisione e l’aggiornamento delle politiche nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti bisognerà attendere il 2020 e addirittura il 2023 per il controllo dell’attuazione degli impegni; il 2020 è anche l’anno in cui dovrebbe essere reso completamente disponibile il fondo comune da cento miliardi di dollari all’anno, destinato al trasferimento delle “tecnologie pulite” ai paesi a scarsa industralizzazione (un buon business per molte aziende occidentali), mentre nel frattempo gli incentivi all’uso del petrolio potrebbero continuare a ricevere la modica cifra di cinquecento miliardi di dollari all’anno.
Sulla revisione e l’aggiornamento delle politiche nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti bisognerà attendere il 2020 e addirittura il 2023 per il controllo dell’attuazione degli impegni; il 2020 è anche l’anno in cui dovrebbe essere reso completamente disponibile il fondo comune da cento miliardi di dollari all’anno, destinato al trasferimento delle “tecnologie pulite” ai paesi a scarsa industralizzazione (un buon business per molte aziende occidentali), mentre nel frattempo gli incentivi all’uso del petrolio potrebbero continuare a ricevere la modica cifra di cinquecento miliardi di dollari all’anno.
Ancora tempo dunque per dare fondo alle riserve di oro nero prima di procedere con convinzione su una via alternativa benché la ricerca scientifica abbia da tempo precisato che siamo in grave ritardo rispetto ai cambiamenti da effettuare.
Riassumendo, si può dire che è stato creato un quadro di riferimento che addirittura vede come traguardo il contenimento del rialzo della temperatura media ben al di sotto dei due gradi (ovvero un grado e mezzo) sapendo tuttavia che un grado ce lo siamo già giocati e che quindi ci resta un margine strettissimo su cui operare e in cui dovremmo riorganizzare l’intera economia globale dominata dai combustibili fossili.
Questo è il punto.
 Si tratta di uno spazio di manovra eccezionalmente piccolo all’interno del quale si rende necessario abbattere l’uso di petrolio, carbone e gas naturale, smettere di tagliare le foreste e smettere di allevare animali in modo intensivo, ovvero, ridurre drasticamente le quantità di merci in circolazione e colpire al cuore il tipo di economia dominata dall’idea di crescita a cui (noi dei paesi più ricchi) ci siamo abituati. E tutto questo senza intaccare i consumi del trasporto aereo e marittimo, per non parlare dei costi energetici dell’apparato militare mondiale che per definizione non vengono neppure contabilizzati poiché vale il principio che la guerra è una cosa a parte, pianeta da salvare o meno.
Si tratta di uno spazio di manovra eccezionalmente piccolo all’interno del quale si rende necessario abbattere l’uso di petrolio, carbone e gas naturale, smettere di tagliare le foreste e smettere di allevare animali in modo intensivo, ovvero, ridurre drasticamente le quantità di merci in circolazione e colpire al cuore il tipo di economia dominata dall’idea di crescita a cui (noi dei paesi più ricchi) ci siamo abituati. E tutto questo senza intaccare i consumi del trasporto aereo e marittimo, per non parlare dei costi energetici dell’apparato militare mondiale che per definizione non vengono neppure contabilizzati poiché vale il principio che la guerra è una cosa a parte, pianeta da salvare o meno.
L’accordo dunque non impone e non può imporre quanto è sgradito a chi comanda e in ogni caso sarà rivedibile ogni cinque anni.
Semplificando, ci dice che (forse) ci saranno un po’ di soldi a disposizione per riparare i danni prodotti dal caos climatico (sommersione di terre, distruzione di raccolti e infrastrutture, ecc.) ma che non è possibile introdurre nel documento finale ne il concetto di “giustizia climatica” ne quello di “diritti umani”.
Soprattutto, facendo finta di non sapere che la densità energetica del petrolio non è attualmente sostituibile, ci dice che la Green Economy è il nostro futuro, ovvero che lo sviluppo delle energie rinnovabili ci porterà fuori dal pantano in cui ci siamo infilati e che saranno gli investimenti della finanza a modificare gli assetti attuali e ad avviare la de-carbonizzazione, considerato che per raggiungere gli obiettivi individuati entro il 2050 sarà indispensabile lasciare sotto terra i combustibili fossili.
In sostanza, secondo lo spirito di Parigi, sarà questa nuova indicazione “politica” dei grandi e dei piccoli della Terra a far cambiare strada alla grandi Lobbies del settore, e a far dirottare investimenti e strategie di business verso un altro modello di produzione dell’energia: come a dire a chi ha procurato il problema, “ora devi risolverlo”.
Devo essermi perso qualcosa poiché mi era parso che soprattutto negli ultimi anni fosse ormai chiaro che sono le grandi multinazionali che condizionano i governi nelle loro scelte e non il contrario.
Qualche osservatore, del resto, ha fatto notare come al tavolo dei negoziati non fosse stata invitata, ne dunque sia stata ufficialmente rappresentata, nessuna grande compagnia, come a dire, che probabilmente non ce n’era bisogno in quanto gli interessi di “Big Oil” potevano considerarsi già ampiamente rappresentati.
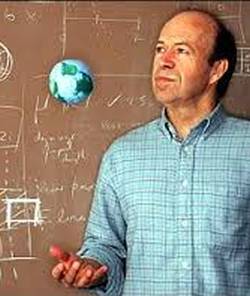
Insomma, il messaggio di Parigi potrebbe essere ironicamente riassunto in una frase del genere “la situazione è critica ma state calmi, non intaccheremo l’economia e salveremo il pianeta”.
James Hansen, uno tra i più importanti studiosi del clima, ha commentato a caldo dicendo che la conferenza ha partorito una frode, un testo che contiene solo promesse, altri come Kumi Naidoo, direttore esecutivo di Greenpeace, ha invece sottolineato i passi avanti definendo l’accordo come la tappa di un viaggio che prosegue.
Ma parlare di luci e ombre sarebbe riduttivo e come al solito troveremo anche nelle analisi più accurate dei prossimi giorni, sostenitori del sì -si tratta di un risultato importante- e del no -si tratta di un fallimento -.
Più banalmente vorrei sottolineare che da una conferenza di questo genere sarebbe stato difficile avere preteso di più, considerati i veti incrociati e le ambizioni dei singoli stati che non intendono mettere in discussione il tema centrale della crescita economica.
 Quel che è certo è che adesso il tema del caos climatico e del suo rapporto con un modello di sviluppo energivoro che impatta disastrosamente sugli ecosistemi e sulle comunità umane, non potrà più essere messo in discussione.
Quel che è certo è che adesso il tema del caos climatico e del suo rapporto con un modello di sviluppo energivoro che impatta disastrosamente sugli ecosistemi e sulle comunità umane, non potrà più essere messo in discussione.
Come ho scritto appena qualche giorno fa su Il Tirreno, tecnicamente siamo di fronte ad un generale “tipping point”, ovvero ad punto di “non ritorno ecologico” oltre il quale si manifestano in modo esponenziale i ritorni negativi del processo che abbiamo messo in moto.
Quanto l’accordo di Parigi potrà incidere concretamente sui pessimi scenari che ci attendono, lo vedremo, personalmente continuo a restare scettico sulla capacità dell’establishment di comprendere davvero quanto sta avvenendo sotto il profilo chimico/fisico al pianeta e quindi, come tale sovrastruttura possa essa in grado di organizzare una risposta efficace.
 Una risposta che peraltro non può prescindere da una profonda modifica dell’esistente, ragione per cui appare quanto meno azzardato confidare che un cambiamento di tale portata possa venire da coloro (individui e gruppi) che sul mantenimento dell’attuale modello economico e sociale fondano le loro posizioni di privilegio e di potere.
Una risposta che peraltro non può prescindere da una profonda modifica dell’esistente, ragione per cui appare quanto meno azzardato confidare che un cambiamento di tale portata possa venire da coloro (individui e gruppi) che sul mantenimento dell’attuale modello economico e sociale fondano le loro posizioni di privilegio e di potere.
Come ho scritto, appare più ragionevole e concretamente fattibile, sviluppare in tempi brevi la costruzione di una resilienza locale che significa iniziare da subito a ridisegnare i flussi di energia e di materia che caratterizzano ciascun territorio secondo una logica “carbon neutral” e di economia circolare, riducendo rapidamente le emissioni climalteranti e organizzando in loco (e non in mega impianti) la produzione di energia rinnovabile e la fornitura di servizi, sviluppando una forte agricoltura locale stagionale e non monocolturale, investendo in progetti di conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.
Piuttosto che lasciare che qualcuno provveda per noi, in questo caso si tratta di operare direttamente e non per delega, in modo orizzontale e non verticale (verticistico), affinché diminuisca progressivamente non solo la pressione che esercitiamo su tutte le risorse del pianeta ma anche la concentrazione di denaro e di poteri che attualmente fanno sì che il 99% della ricchezza globale sia posta nelle mani dell’1% dei nostri concittadini.
Per ottenere risultati tangibili è dunque fondamentale comprendere che dovremo fare con meno e fare bene e che non dobbiamo avere paura nel pronunciare il termine -decrescita- in quanto la cosidetta “crescita economica e materiale”, evidentemente risulta ormai appannaggio dei soliti noti e, come tra gli altri spiega molto bene Tim Jackson nel suo “Prosperità senza crescita”, nel provocare alti costi sociali non contribuisce più al “sentirsi bene delle persone”.
A partire dalle singole comunità territoriali, è allora indispensabile riorganizzare il sistema economico e sociale puntando dritto verso un modello ecologico autenticamente sostenibile, inclusivo, equo e stazionario, un modello che si sta già sperimentando con varie modalità in realtà rurali e urbane di tutti continenti e che probabilmente può permetterci di affrontare in modo intelligente la transizione che ci attende.




